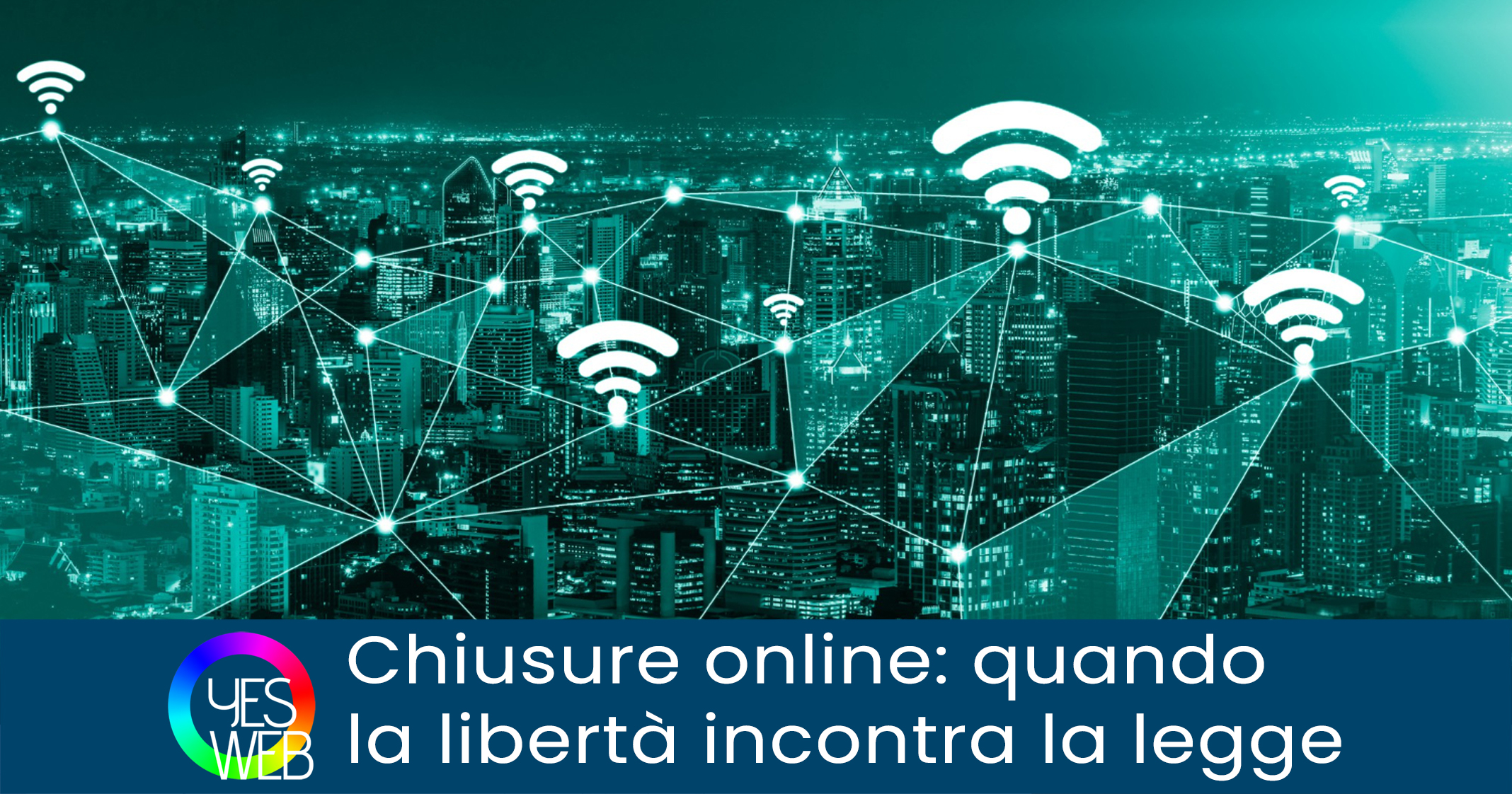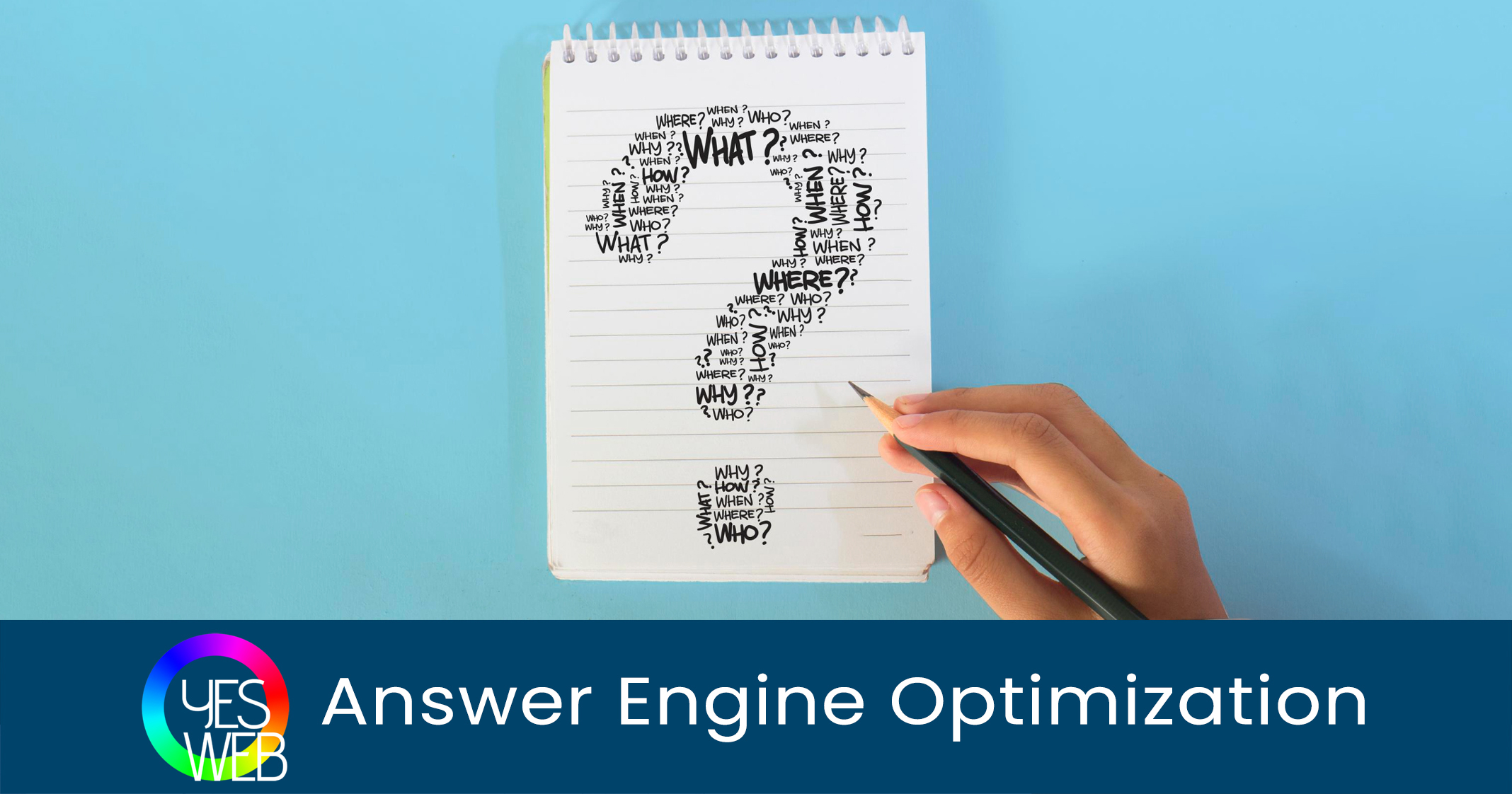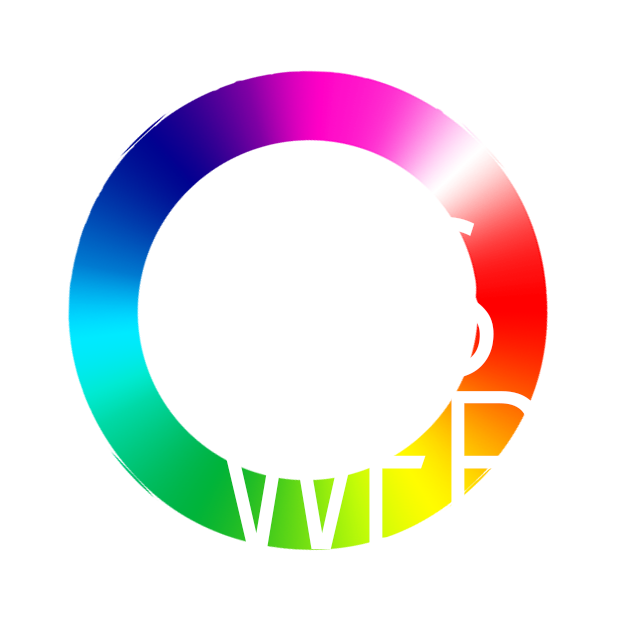Influencer, competenza e controllo: la Cina ridefinisce le regole
È notizia degli ultimi giorni che la Cina ha introdotto una normativa che potrebbe ridisegnare la professione degli influencer: chiunque intenda parlare di argomenti “seri”, come medicina, finanza, diritto, educazione, politica, ecc, dovrà dimostrare di avere la preparazione adatta. In sostanza non basta avere tanti follower o essere bravi a intrattenere, ma se parli di temi che toccano la conoscenza specialistica, il contenuto deve venire da chi ha un titolo riconosciuto a farlo, almeno nel paese del dragone.
Cosa stabilisce la nuova regolamentazione
La norma, operativa da ottobre 2025, prevede che gli influencer che trattano di ambiti sensibili debbano provare formazione o qualifica nel settore in questione.
Inoltre, sarà vietata la promozione ostentata del lusso (luxury flaunting), le piattaforme devono etichettare contenuti generati da AI, mentre la figura degli influencer sarà regolamentata sotto la legge pubblicitaria cinese.
Questo rappresenta, per molti analisti, un cambio di paradigma: non ci saranno più solo influencer che intrattengono e promuovono, ma influencer competenti e preparati quando si trattano temi seri.
Perché la Cina lo fa
Al centro, almeno secondo il governo cinese, ci sono due motivi principali:
- Combattere la disinformazione: nei settori medico, finanziario, educativo la diffusione di contenuti imprecisi è vista come rischio.
- Controllo culturale e reputazionale: lo Stato vuole dare un segnale chiaro che il mondo digital-influencer non è uno “spazio libero” senza regole, specialmente quando ha grande impatto sociale.
E in Italia/Europa? Potrebbe succedere anche da noi?
È interessante chiedersi se questa regolamentazione può essere solo un caso isolato alla Cina, o può dare anche ai governi occidentali spunti per riflettere su una regolamentazione più stringente di questa professione.
Attualmente, in Europa non esiste ancora una normativa che richiede agli influencer di avere un titolo accademico per parlare di finanza, medicina o diritto, ma esistono delle linee guida e codici di condotta. A questo scopo la European Commission ha pubblicato principi guida per il marketing degli influencer e la trasparenza degli annunci. In Italia, alcuni casi hanno mostrato i rischi della promozione non trasparente (vedi influencer che promuovono prodotti sanitari senza adeguata chiarezza).
Quali scenari potrebbero verificarsi
Vediamo insieme ora cosa potrebbe succedere se fossero introdotte delle regolamentazioni nel nostro continente:
Ipotesi 1: regolamentazione soft
L’Europa potrebbe introdurre norme più rigide sulla trasparenza, sull’etichettatura delle sponsorizzazioni e sui requisiti minimi per chi tratta tematiche forti (finanza, salute), senza però richiedere una titolo di studio specifico o di alto livello, facendo in questo modo un “passo intermedio”.
Ipotesi 2: standard di competenza
Potrebbe emergere l’idea che, se un influencer parla di finanza o medicina, debba essere “certificato” o affiliato a professionisti qualificati (es: collabora con un medico, un commercialista). Non necessariamente un titolo di studio specifico, ma competenza dimostrabile.
Ipotesi 3: aspirazione alla Cina
In uno scenario più radicale, potrebbe venir richiesto che chi ha molti follower e tratta temi sensibili abbia un titolo o una qualifica verificata, perciò simile al modello cinese. Probabile poco realistico in Italia nel breve, ma non da escludere come “modello di riferimento”, anche se in questo caso si dovrebbe capire come conciliare questo approccio con la libertà di parola e opinione.
Vantaggi e criticità di un approccio di competenza
I vantaggi, nemmeno a dirlo, sicuramente riguarderebbero una maggiore affidabilità del contenuto, in modo che il pubblico possa fidarsi di chi parla e divulga, e questo dovrebbe portare a una riduzione della disinformazione, soprattutto in settori delicati e/o polarizzati. Inoltre, e non è poca cosa, avremmo una migliore reputazione del “lavoro influencer” come professione.
Ma anche l’altra faccia della medaglia, quella delle eventuali criticità non è da sottovalutare. Infatti il solo rischio di “barriere all’ingresso” potrebbero limitare la creatività e la spontaneità di chi crea un contenuto, oltre al dover individuare un metodo univoco per capire come stabilire chi è “preparato”. E non basterebbero sicuramente le sole certificazioni, titoli o collaborazioni.
Inoltre, e anche questa evenienza non è di poco conto, potremmo avere una possibile sovrapposizione tra “influencer” e “esperto professionale”, cambiando la prospettiva delle persone verso la diffusione dei contenuti.
Inoltre non dobbiamo scordarci che In Italia e in Europa, l’equilibrio tra libertà di espressione, creatività digitale e protezione del pubblico è più delicato, perché il contesto istituzionale è diverso.
Perché conviene al settore “ influencer & marketing” tenere d’occhio questa trasformazione?
Se analizziamo dal mero punto di vista delle opportunità, l’essere preparati in un determinato settore potrebbe portare le agenzie e i brand a prepararsi per un futuro più regolamentato, in modo da non essere impreparati per un eventuale normativa più stringente, e ottenere un vantaggio competitivo.
Dal punto di vista degli influencer e creator, capire che “essere competenti” può diventare un criterio di differenziazione, non basato soltanto su “tanti follower”, ma “autorevolezza nel tema”, sicuramente creerà un engagement più consapevole meno polarizzante.
Per il pubblico/consumatore: si alzerebbe l’asticella della credibilità dei contenuti. Infatti il pubblico chiede sempre più “chi mi parla?” e “con quale competenza?” con un eventuale normativa questa domanda avrebbe una risposta.
Per i regolatori europei, o nazionali, questo è un laboratorio interessante per studiare come garantire equilibrio tra libertà digitale e protezione dei cittadini. La Cina mostra un modello rigido, ma in futuro l’Europa potrebbe scegliere una via più conciliante o ibrida.
La recente regolamentazione degli influencer in Cina introduce qualcosa di nuovo, cioè la competenza certificata come prerequisito per chi comunica su temi importanti. Per l’Italia e l’Europa, non è detto che verrà preso lo stesso percorso, ma il segnale è comunque forte. Con il mondo digitale che evolve, l’“influencer” non è più solo “creatore di contenuti”, ma può diventare anche “disseminatore di conoscenza”, con responsabilità ulteriori.
In questo contesto, i professionisti del marketing, i creator e i brand dovrebbero iniziare a porsi domande: come posso dimostrare competenza? Come posso collaborare in modo trasparente e credibile? E come si evolverà la regolamentazione?
Nel panorama italiano, le opportunità sono ancora ampie: maggiore autorevolezza può diventare un vantaggio competitivo, anche se si dovrebbe investire sulla fiducia e sulla responsabilità degli haters o di chi pubblica contenuti falsi. In definitiva la Cina ci offre un “modello estremo”, un laboratorio, grazie al quale possiamo guardare in casa nostra e chiederci se siamo pronti al salto successivo, e se sì, in che modo. A questa domanda, e per ogni tua necessità, possiamo rispondere noi di yes -web, che da anni affianchiamo le aziende e i professionisti per aiutarli a fare la scelta giusta e coerente.